Quel desiderio di farcela (e di essere capito)
I momenti febbricitanti che annunciano l’imminente fine della scuola. Giorni di ansia e attesa. Non semplici da governare, specie se c’è qualche materia da recuperare. Una situazione comune agli studenti di ieri come a quelli di oggi. Ma come i ragazzi di questo tempo vivono il proprio fine anno scolastico? Il racconto di uno psicologo scolastico. Dalla prima linea.
23 maggio 2025
Lo psicologo scolastico
di Lorenzo Buggio

Chi se la ricorda, la fine dell’anno scolastico?
Io sì, e me lo ricordo bene. Non tanto per l’università, che nel mio caso è andata avanti con una certa regolarità, quanto per il liceo, che invece era più governato dalla filosofia del “chi vivrà, vedrà”. Ogni anno, dalla prima alla quinta, maggio arrivava sempre con qualche materia da recuperare, altre da tenere a galla, e una voglia immensa di chiudere tutto il prima possibile e tuffarmi nell’estate.
Anche oggi, che parlo di ferie e non più di vacanze, mi tornano in mente quei momenti febbricitanti, misti di ansia e attesa, con un sorriso appena accennato che si affaccia nei ricordi. Momenti difficili, certo, ma anche formativi: oggi so che hanno contribuito a plasmare il mio modo di pensare e affrontare la vita, anche se ne ho capito il senso solo dopo.
Ma è ancora così? Come vivono i ragazzi di oggi la fine della scuola?
Un utile filo conduttore
Senza pretese di scientificità, posso però dire di aver avuto un’osservazione diretta grazie al mio lavoro attuale come psicologo scolastico. In questo ruolo, sto vivendo in prima persona il modo in cui gli studenti affrontano questo periodo dell’anno. E come sappiamo, quello che spesso non si dice agli insegnanti, si riesce (o si vuole) dire allo psicologo. Tranquillizzo subito: la privacy è garantita. Anche se non ho pronunciato un giuramento come i colleghi medici, anche noi psicologi seguiamo un codice deontologico che rispetto — e difendo — con convinzione.
Ciò che condivido qui non ha lo scopo di rivelare storie personali, ma di trarre un filo conduttore utile su cui riflettere, nella speranza che questo diventi qualcosa di più di una semplice chiacchierata.
Un esercizio utile per rompere il ghiaccio — soprattutto a scuola, dove la figura dello psicologo è spesso ancora avvolta da un alone di diffidenza — è quello che chiamo “la mappa del sé”. Non so se esista davvero un nome tecnico, ma i ragazzi hanno imparato a conoscerla così, e io mi ci sono affezionato.

La mappa del sé
La mappa del sé è uno strumento semplice: al centro, il proprio nome o soprannome, quello che più ci rappresenta. Da lì, partono quattro rami, ognuno collegato a un aspetto fondamentale:
Le relazioni (quelle principali)
Le emozioni (quelle provate recentemente)
Gli obiettivi
I desideri
Oggi voglio soffermarmi proprio su questi ultimi due. Non li definisco mai in anticipo: lascio ai ragazzi la libertà di interpretarli. Quando mi chiedono “Cosa intende per desiderio o obiettivo?”, rispondo: “Ciò che intendi tu”. Dopo questa domanda, che non manca mai, e qualche sguardo perplesso o infastidito, tutti scrivono. Chi fa un elenco, chi un solo punto. Ma due risposte tornano sempre:
“Finire l’anno senza debiti o senza essere bocciato”
“Essere felice/ottenere quello che desidero”
Alla prima, rispondo spesso: “Come mai è così importante finire senza debiti?”
La reazione è quasi sempre la stessa: uno sguardo a metà tra il sospetto e l’irritazione. “Ma come, non lo sa? Non aveva paura anche lei?” Rispondo sinceramente: sì, certo, mi spaventavano. Ma non li ho mai visti come un obiettivo dell’anno, piuttosto come un ostacolo da superare. Mi interessa capire perché per loro sia diventato l’obiettivo.
Lo sfogo di una ragazza
Ed è qui che emerge il nodo: “Perché se non riesco, deludo i miei genitori, gli insegnanti. E mi vergognerei.” Genitori, insegnanti: questo non è un attacco. Non voglio dire che gli studenti abbiano sempre ragione e voi sempre torto. Vi invito, anzi, a leggere con attenzione. Proprio ieri ho avuto un colloquio con una ragazza in difficoltà. È arrivata in ritardo, con il volto coperto dalle lacrime. Si è seduta sulla “sua” sedia — quella che ormai conosce bene — e si è sfogata. In mezzo a tanti singhiozzi, ha detto una frase che mi è rimasta impressa: “Non ho recuperato matematica. L’ho appena scoperto. So che i miei genitori mi vogliono bene, ma me ne vorranno anche se sarò bocciata?”. Evitate commenti semplicistici del tipo: “Chissà cosa le avranno detto” o “Povera, sarà sotto pressione”. I genitori, in questo caso, l’hanno sempre accolta con dolcezza, indipendentemente dai voti. L’insegnante le aveva solo chiesto di prepararsi per bene per l’ultima verifica, che tra l’altro lei ha superato, anche se non abbastanza per recuperare tutto.
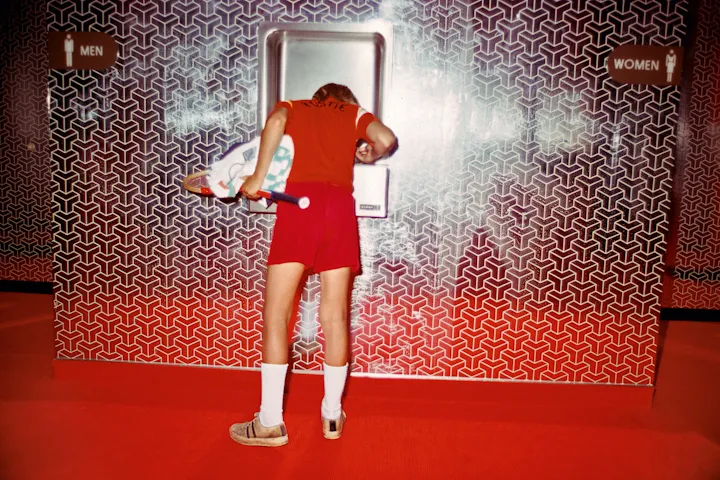
La foto giusta
Allora, qual è il problema? Il problema, spesso, non è nella scuola o nella famiglia. Certo, esistono genitori assenti o iperesigenti, insegnanti incoerenti che predicano l’idea che “non siete il vostro voto” ma poi giudicano solo in base a quello.
Ma nella maggior parte dei casi il problema è un altro: viviamo in una società che non accetta il tempo delle cose. Oltre alla psicologia, ho una passione — e anche un secondo lavoro — la fotografia.
Un fotografo mi disse una volta che la foto giusta non è mai la prima che scatti. A volte torni a casa a mani vuote. Altre, scatti cento volte per salvarne una. Ma senza tutte quelle prove, quella singola immagine “giusta” non esisterebbe. Ecco: così è anche il percorso scolastico, e in generale quello della vita. Per fortuna — e non certo per merito mio — quando mi trovavo davanti a una difficoltà scolastica, avevo intorno persone che mi aiutavano a capire che quell’ostacolo non era la fine, ma solo una tappa.

Oltre le rassicurazioni
Una frase che non sopporto, e che purtroppo sento spesso, è: “Essere bocciati significa perdere un anno.” Ma perché lo si considera perso? Se ci si è impegnati, ma non si è raggiunto il risultato, si è comunque imparato qualcosa. E se non ci si è impegnati, allora forse c’era bisogno di una lezione diversa, più profonda.
Dimentichiamo facilmente che, fino all’ultimo giorno della nostra vita — e forse anche dopo, ma su questo non abbiamo ancora informazioni — continueremo a imparare, sbagliare, provare. È l’unico modo per andare avanti. Quindi, se siete insegnanti, ricordatevelo quando vedrete un vostro studente in crisi.
Se siete genitori, quando vedrete vostro figlio o vostra figlia in difficoltà, non cercate solo di rassicurarli: aiutateli a capire che si può sbagliare, senza che questo significhi fallire. E se non rientrate in queste due categorie ricordatevelo per voi stessi: è attraverso gli errori che, passo dopo passo, possiamo scoprire qual è il nostro vero desiderio.



