Giuseppe De Rita (Censis): La “zona grigia” e la responsabilità della speranza
Il fondatore del Censis interviene per commentare i risultati della ricerca del Centro sulla relazione che intercorre tra responsabilità e speranza nella società italiana. Le non si sentono protagoniste in un contesto di “soggettivismo spento” dove, tuttavia, continuano a cercare un altrove che dia un indirizzo concreto alla propria vita. La missione della Chiesa. L’impegno dei cattolici, l’orgoglio dell’annuncio.
25 aprile 2025
La Chiesa in uscita
Conversazione con Giuseppe De Rita a cura di Nicola Varcasia

Il 29 marzo 2025, nella basilica di San Giovanni in Laterano, a Roma, si è tenuta una singolare conferenza sulla “Responsabilità della speranza”. (Highlights della presentazione https://www.youtube.com/watch?v=51-RZLPaBqw&t=8s)
L’incontro non è stato uno dei tanti sul tema giubilare, ma aveva una sua particolarità: era la riedizione del famoso convegno passato alla storia come il “Febbraio 74”, voluto dal cardinale Ugo Poletti, antesignano di quella che oggi conosciamo come la Chiesa in uscita di Papa Francesco e che rappresenta una delle principali eredità del suo pontificato. Tra i partecipanti di allora, c’era anche Giuseppe De Rita che, a 50 anni da quell’esperienza, ha desiderato fortemente di riallacciarsi a quel filo.
Il fondatore del Censis, oggi 92enne, ha illustrato le ragioni di questa urgenza culturale su Avvenire e sul Corriere della Sera, anticipando i temi della ricerca presentata per l’occasione. .CON ha approfondito una questione che ha molto a che vedere con la sua mission di andare al largo.
Presidente, che cosa è emerso dalla ricerca? Gli italiani non sperano più?
La speranza è un fatto soggettivo, tra gli italiani ci può essere chi ne ha tanta e chi ne ha poca, quello che manca alla società è la capacità di guardare oltre, di pensare e progettare un percorso di ulteriore crescita, umana, sociale e magari anche economica. Alla società italiana manca una visione di progresso.
Come si declina questa mancanza?
Da un lato gli italiani non si sentono più protagonisti di una storia, addirittura hanno la sensazione che qualcun altro stia scegliendo per loro, dall’altro cercano ancora un altrove in grado di dare un indirizzo alla loro vita. La trascendenza o comunque un cammino spirituale, sono ancora un’esigenza profonda, ma i linguaggi oggi sono talmente cambiati, che spesso rifuggiamo dalle liturgie tradizionali e preferiamo una spiritualità soggettiva.
Lei ha riassunto la “zona grigia” civile e religiosa in cui viviamo con l’idea del “non vado a messa e non voto”. Dove risiede la possibilità di superare questo soggettivismo spento?
La zona grigia è la zona dell’indistinto, del tralasciare, potremmo dire in termini religiosi: dell’omissione. In questo sono due zone, quella religiosa e quella civile, che possono sovrapporsi. In parte 40 anni di cultura soggettivistica hanno consumato anche il soggettivismo, quindi la spinta ad affermare sé stessi, i propri desideri, le proprie ambizioni… fatica a trovare stimoli nuovi. Ma in parte è anche l’“offerta” di un oltre, che è poco stimolante, non è solo colpa del soggettivismo, se non si va a messa e non si va a votare, è anche la politica e un certo modo di fare chiesa, che non sono in grado di intercettare quel bisogno di “altrove”.

Nell’articolo sul Corriere ha parlato di un cattolicesimo che ha accettato di diventare una subcultura, perdendo il suo slancio verso l’avanti e verso l’alto, ricordando Teilhard de Chardin.
Mi viene da pensare che Teilhard era morto il giorno di Pasqua e anche papa Francesco è morto in quella stessa luce di resurrezione. Nel pensiero teilhardiano l’evoluzione è centrale, ma non un’evoluzione naturale, quasi spontanea e inevitabile: egli fa riferimento ad un’evoluzione in cui è necessario credere affinché si realizzi; l’umanità e la chiesa con essa, deve credere nello sviluppo, così come ogni uomo deve credere nel suo progredire.
È questo anche il fulcro della Chiesa in uscita?
La Chiesa in uscita è stata una grande intuizione di papa Francesco, l’approccio dell’“ospedale da campo” credo fosse più un modo di esortare chi doveva mettersi in cammino, che non la sua reale lettura del mondo contemporaneo. La chiesa deve aprirsi al mondo in una logica di servizio e di comprensione delle realtà del mondo. Ma tradiremmo il suo pensiero se pensassimo che l’ospedale da campo fosse la sua visione del mondo contemporaneo. L’umanità è molto di più e può offrire molto di più, anche alla Chiesa.
Come?
A dicembre ricorreranno i 60 anni della Gaudium et Spes, sono sicuro che sarà il momento per la Chiesa di riflettere su come guardare all’umanità come a qualcosa di più che un ospedale da campo.
Nella conferenza di Roma, Massimo Cacciari ha detto che serve un’alleanza tra credenti e non credenti sul lavoro dello spirito. Quali sono gli strumenti per rafforzare il nostro “armamentario spirituale”?
Non credo si tratti tanto di rafforzarlo, come accennavo prima forse è il caso di aggiornarlo, non tanto nella sua essenza profonda, ma nel suo approccio quotidiano, deve sempre reincarnarsi nell’uomo di oggi. L’uomo di oggi deve riconoscere il nostro “armamentario spirituale” (come lo chiama lei), come qualcosa di suo. Il messaggio è cattolico, perché è universale, può parlare alla realtà di tutti gli uomini, in tutte le epoche, anche al non credente e il non credente vi può riconoscercisi, pur non credendo.
A quali condizioni ciò può accadere?
L’importante, come diceva Cacciari il 29 marzo, è che il lavoro dello spirito sia un lavoro di relazione: io trovo me stesso e la mia realtà più profonda, nella relazione con gli altri. Un’alleanza di questo tipo avrebbe un valore enorme per affrontare i rapidissimi cambiamenti in atto, sul piano umano, sociale e direi anche economico.
La Chiesa oggi sembra invece un po’ in difficoltà in questo approccio, come mostra il recente caso del documento finale nel sinodo…
La Chiesa entra in difficoltà quando si concentra troppo sui problemi “ad intra”. Quando è l’apparato che riflette su sé stesso, basta una piccola divergenza su un problema interno perché la macchina si blocchi. Al contrario, quando la Chiesa riflette sul suo movimento ad extra, sul suo andare nel mondo per incontrare e incarnarsi nelle ansie e nelle aspirazioni degli uomini, allora ritrova armonia e diciamolo pure, l’orgoglio dell’annuncio.
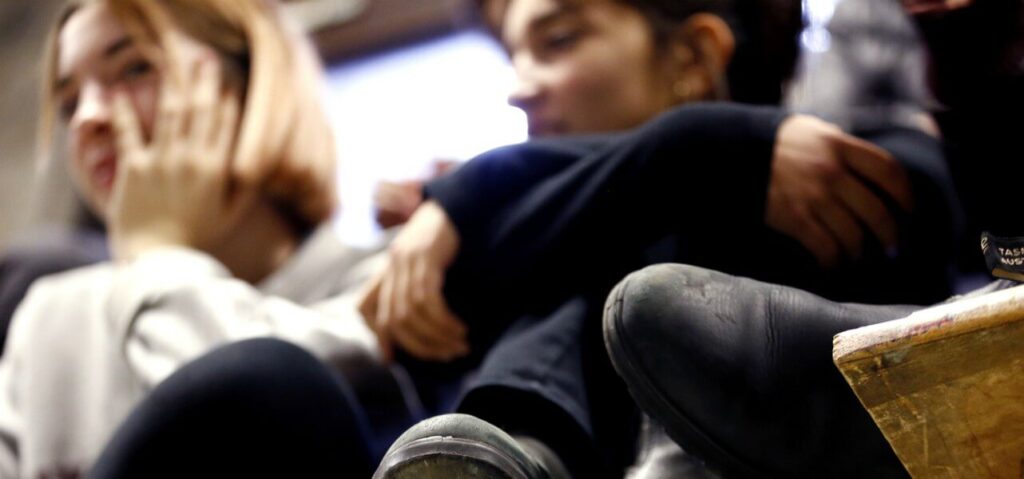
Fare cultura è cercare di capire i problemi di oggi. Per questo ha citato l’orgoglio della badessa di Bingen?
Ildegarda – che era una delle autrici preferite di mia moglie – affrontò senza alcun timore l’imperatore Barbarossa, ricordandogli che ogni dominazione umana è incerta e transitoria, addirittura lo minaccia con una spada! Certo è un linguaggio medievale, ma deve restare quell’orgoglio di contrastare i potenti che adottano solo la logica della forza. Esiste un’altra forza, la spada di Ildegarda, che è in grado di fermare chi oggi crede di fare l’imperatore.
Che cosa rappresenta?
Quella spada oggi è proprio la fiducia nella possibilità, nello sviluppo umano, di ogni uomo e di tutto l’uomo, quel messaggio universale di cui parlavamo prima. La forza dell’individuo che crede nel suo valore e che vede la possibilità di realizzare le sue aspirazioni ha sempre vinto sui tentativi di omologazione che, in fondo, tengono uniti gli eserciti, con la divisa o senza, su cui si basa la logica della forza dei potenti di questo mondo.



