Daniele Mencarelli: «Ridiamo la parola ai testimoni»
“Parlare di testimone in letteratura è una cosa che ci colpisce fino a un certo punto. Perciò ai ragazzi propongo sempre di spostare questa parola in un’aula di tribunale ed è vertiginoso. La stessa parola manda in galera un innocente e scagiona un colpevole. Farsi testimone prevede qualcosa di più grande e chiede di essere osservato, l’osservanza verso qualcosa di più grande”. L’autore de La casa degli sguardi e Tutto chiede salvezza parla delle ragioni per cui si è venuto a incrinare il rapporto tra la letteratura contemporanea e la realtà. E da scrittore avvia una riflessione su quanto espresso da Leone XIV: «Disarmiamo le parole e disarmeremo la Terra»
23 maggio 2025
Il presente esiliato
Conversazione con Daniele Mencarelli a cura di Nicola Varcasia
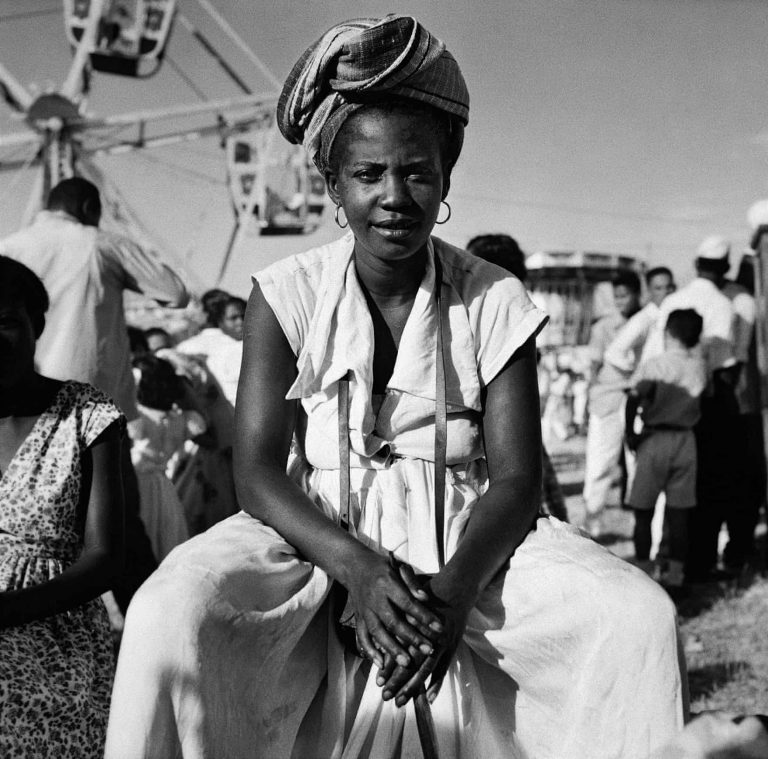
‘Andare al largo’ con Daniele Mencarelli significa uscire dal circuito letterario per parlare di tutto quello che dovrebbe interessare davvero la letteratura. Spoiler: la realtà. Il dialogo con l’autore di romanzi di enorme successo quali La casa degli sguardi, sua opera d’esordio da cui Luca Zingaretti ha di recente tratto il film omonimo, Tutto chiede salvezza e Fame d’aria,parte infatti dalla constatazione che quel rapporto oggi si è incrinato.
Perché questo scollamento tra letteratura e realtà?
La letteratura contemporanea e soprattutto la narrativa si nascondono un po’ troppo nel passato. L’esercizio fondamentale di memoria e di resistenza rispetto a quello che è accaduto dovrebbe essere bilanciato o superato dalla visione del presente che un autore tenta rispetto a quello che vive oggi.
È un problema di tematiche?
Ci sono tanti temi narrativamente sovraesposti e molti altri che non vengono raccontati. Questo mi fa un po’ soffrire perché credo che la grande sfida di uno scrittore sia leggere il presente e, attraverso strumenti come il romanzo o il racconto di fantasia, avvertire di un pericolo, di una piega che hanno preso determinati fattori. Invece la funzione testimoniale della letteratura rispetto al presente non esiste più.
Questa tendenza riguarda solo la letteratura?
Il presente e la realtà sono due elementi esiliati non solo nello spazio letterario. Per ventun anni mi sono occupato di prodotto audio visivo, che più di tutti influenza gli immaginari. Qui il rapporto tra realtà e rappresentazione non è solo incrinato, ma totalmente rimosso ed è pericoloso.
Qual è un tema sovraesposto?
Pensiamo alla volontà di rimozione che c’è stata rispetto al Covid.
Perché?
Il presupposto è che non dobbiamo testimoniare quello che accade, ma quello che il pubblico si aspetta. Nelle grandi aziende che producono contenuti culturali si sono affermate figure provenienti dal marketing e dalla comunicazione, che inseguono il pubblico invece di pensare a offrire un contenuto perché è urgente o importante dal punto di vista civile, politico e umano.
Come se ne esce?
Questo è l’andamento generale, poi naturalmente ognuno ha la possibilità di percorrere strade diverse. Lo dico dopo aver toccato con mano il fatto che questo Paese ha gravissime difficoltà che nessuno racconta.
Ad esempio?
Si parla tanto della trasformazione dell’auto da carburanti fossili a un consumo elettrico, per motivi climatici. Condivido il punto, però nessuno dice che la macchina è il primo motivo di morte tra i 14 e i 20 anni in tutto il mondo. È come se ci fossero dei temi che prevalgono su altri. Come succede per la sanità.

In che senso?
C’è un grande tema che in Italia facciamo finta di non vedere, ma che tocchiamo con mano e con terrore ogni volta che ci capita di incontrarlo: la sanità, che ormai è una scatola vuota. Per non parlare di quella riferita all’autismo. Esistono mille emergenze e nessuno prova a raccontarle: né la letteratura, né tantomeno la politica.
Leone XIV ha detto: «Disarmiamo le parole e disarmeremo la Terra», che cosa significa per uno scrittore disarmare le parole?
Il nuovo Papa ha toccato un tema centrale, il rapporto dell’uomo con il principale strumento di relazione che ha con se stesso in primis e con gli altri: la parola. Viviamo dentro una lingua che vive una distorsione assoluta rispetto alla parola.
Come possiamo accorgercene?
Oggi si fa un uso massiccio di un linguaggio che tende a medicalizzare l’uomo. Tanti ragazzi si definiscono ansiosi, in automatico, senza capire che quel termine rischia di diventare una spada di Damocle contro loro stessi. Dobbiamo disarmare le parole non solo in funzione della pace, ma anche in funzione dello sguardo che l’uomo ha di se stesso. Disarmare le parole per tornare a una lingua che sia più prossima e più clemente rispetto all’umano.
Ne La casa degli sguardi, la visione ravvicinata di qualcuno che sa stare vicino al dolore innocente diventa il principio del riscatto. Come si fa a ritrovare quello sguardo per essere clementi con se stessi?
Se ripenso alla mia esperienza, non ho mai perso lo sguardo. Quello che ho vissuto nei primi 27 anni della mia vita, soprattutto dai 17 ai 27 è stata, se vogliamo definirla così, una negazione di un certo modo di guardare alla realtà. Mi negavo rispetto allo sguardo che avevo sulla realtà. Nei momenti di lucidità, poi, tornava a prevalere il Daniele consapevole e quello sguardo tornava a essere vivo, vibrante.
Talmente vibrante dal volerlo raccontare.
Oggi abbiamo totalmente dismesso le parole che approcciavano all’uomo attraverso le discipline dell’umano, la letteratura, la filosofia, per non parlare della religione. Ma, se partiamo dal presupposto che tutto ciò che avvicina l’uomo a se stesso e lo attende da sempre è patologico, ci allontaniamo ancora di più. Io mi sono rialfabetizzato intorno a questi temi attraverso la poesia, il lavoro e tante esperienze diverse e sovrapposte che, messe tutte assieme, hanno fatto ripartire il ragazzo, l’uomo.
Il ritorno a questi temi è stato fondamentale?
Il problema nasce quando partiamo da una narrazione di noi stessi profondamente disumana. Quando l’uomo pensa di poter vivere distaccandosi dalla sua natura e non contemplandola, come ha sempre fatto, anche attraverso quelle discipline che guardavano e domandavano, senza la velleità che abbiamo oggi, di risolvere l’irrisolvibile: la nostra natura.

È il paradosso dell’esistenza.
Siamo nati senza chiederlo, moriremo allo stesso modo, in mezzo a questi due temi ce n’è un terzo che fa sballare ancora di più il banco: l’amore. Questi temi hanno da sempre agito nell’uomo in un certo modo e mi ritrovo spesso a stupirmi dello stupore, che appaia sorprendente quanto l’uomo possa soffrire rispetto all’esistenza.
Rispetto al presente di guerra che viviamo, come abbiamo fatto a edulcorare il sentimento della sofferenza, che ci viene sbattuto continuamente davanti?
C’è un’assuefazione assoluta non tanto al dolore, quanto alla visione dell’aberrante e dello sconvolgente. Lo sconvolgente non sconvolge più, il trasgressivo non trasgredisce più. Tutta l’Europa si sconvolse per quel primo bambino ritrovato sulla spiaggia turca (Aylan, nel 2018) e ne seguì una mobilitazione internazionale a partire da questa immagine terribile e disumana. Nel giro di un anno sono morti altri bambini: è un drammatico test per capire come l’assuefazione abbia lavorato in modi diversi in tutti noi e ci abbia in qualche maniera devastati.
Un umano troppo poco umano?
Siamo diventati immunizzati alla compassione, lo vediamo anche dall’uso delle parole. Se pensiamo che per Leopardi la poesia doveva essere sentimentale e patetica e all’uso che facciamo oggi di questi due aggettivi già capiamo di cosa è stato fatto.
Ricostruire un rapporto con la lingua non sarà facile.
Mi rincuora vedere come i nativi digitali abbiano un grande desiderio di riappropriarsi di una complessità che gli adulti non sono in grado di restituire. Il problema infatti sono loro, non i ragazzi. La sfida è come ricomporre una lingua che parta dai bisogni dell’uomo e non li renda immediatamente patologici o singolari.
In che senso singolari?
Oggi qualsiasi tema umano viene affrontato in una chiave non più collettiva e orizzontale, ma esclusivamente individuale. È il singolo che deve risolvere i suoi problemi e il suo rapporto con la vita. Anche se questi problemi riguardano la natura di tutti e forse sarebbe più giusto e naturale affrontarli tutti assieme, come è stato sempre fatto e come aveva ricordato Claudio Damiani, un amico e un maestro per me, alla fine degli anni Novanta quando scrisse Attorno al fuoco. Ritrovare quella dimensione, per far capire a ciascun ragazzo che lui non è il solo a vivere certi sentimenti.
Verrebbe da dire che è una questione di intelligenza naturale più che artificiale.
È un tema che si aggiunge a quello che abbiamo detto. Ma non è mai un problema dello strumento. Un bisturi in mano a un chirurgo salva la vita a un bambino, un bisturi dato in mano a un bambino uccide un chirurgo. Poi, c’è da dire che siamo anche campioni di dabbenaggine.
Perché?
È vero che sembra di sparare contro la Croce Rossa ma, mentre in America gli sceneggiatori hanno bloccato per un anno la scrittura delle serie per mettere i paletti all’intelligenza artificiale, noi siamo l’unico Paese in cui il Ministero dei Beni culturali e del turismo ha indetto un concorso per ragazzi che premiava la migliore sceneggiatura scritta con l’intelligenza artificiale. Poi si corre sempre ai ripari, ma è tutto un mettere delle pezze.
Ai ragazzi nelle scuole racconti i “tuoi” Giorgio Caproni e Camillo Sbarbaro. Che cosa significano per te questi due poeti?
Caproni è stato il viatico ai primi tentativi di scrittura. Ultima preghiera, dedicata alla madre Anna Picchi, per me giovane 17enne significò scoprire dalla penna di un maestro che con la letteratura, questo gesto che consideravo così lontano rispetto a me, si poteva fare esattamente quello che io volevo fare: dedicare una poesia a una madre.
Sbarbaro?
Resta in assoluto il poeta che ha catturato, per come io non so fare ancora oggi, il mio animo rispetto a quello che provo e che vivo. In Taci anima stanca di godere dice: “Aspetto che la volontà di vivere ritorni”. In certi momenti può capitare che la volontà di vivere, per quello che si attraversa, per i dolori che possiamo vivere o per certi momenti che consideriamo non particolarmente favorevoli, cessi di essere potente per come l’abbiamo provata. Questo non ci rende disumani, ma profondamente umani e vulnerabili.

Cos’è la vulnerabilità?
Nella mia vita, in fondo, la grande rivoluzione è stata questa: accogliere la vulnerabilità. Anche grazie alla fortuna di saperla ridire, scrivere. Una capacità che mi è capitata, non l’ho scelta io. Però la grande rivoluzione è stata quella: uno sguardo che si voleva allontanare che si considerava maledizione e basta, trasformarlo in un elemento di validità e non di invalidità rispetto alla nostra vita.
Torniamo all’arte come testimonianza o addirittura come obbedienza?
Nel momento in cui ti fai testimone, evidentemente obbedisci a qualcosa che tu sai essere più grande di te, che sai di aver visto e ti chiede di essere trasmessa a qualcun altro. Parlare di testimone in letteratura è una cosa che ci colpisce fino a un certo punto. Perciò ai ragazzi propongo sempre di spostare questa parola in un’aula di tribunale ed è vertiginoso. La stessa parola manda in galera un innocente e scagiona un colpevole. Farsi testimone prevede qualcosa di più grande e chiede di essere osservato, l’osservanza verso qualcosa di più grande.



